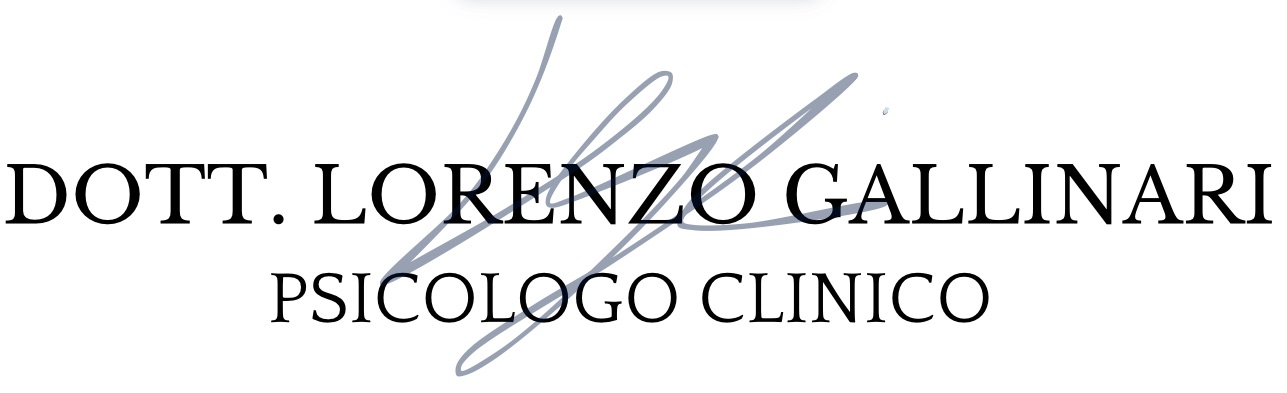C'è un paradosso che attraversa il nostro tempo: abbiamo accesso immediato a tutto, tranne che a noi stessi.
Viviamo nell'epoca del “tutto subito”, dove ogni istante è monetizzabile, ogni emozione convertibile in contenuto, ogni pensiero schedulato tra una notifica e l’altra. E in questo universo isterico, accelerato, performativo — dove anche il dolore deve essere “risolto” in dieci sedute, possibilmente in modalità fast & online — la psicoanalisi appare come un’eresia anacronistica. Lenta. Costosa. Non finalizzata. Inefficiente.
Eppure — forse proprio per questo — è una delle ultime pratiche autenticamente sovversive.
Il tempo lungo del pensare
La psicoanalisi è una pratica del pensiero lento. E pensare, oggi, è un atto anticonformista, ribelle, anacronistico. Non il pensiero strumentale, quello utile, quello da “problem solving”; ma il pensiero come atto riflessivo, come sosta, come vuoto. Come discesa nei propri fondali torbidi. Un processo che non porta da nessuna parte, se non dentro. Come scrive Heidegger in uno dei suoi Holzwege, quei "sentieri interrotti" che attraversano la foresta senza sboccare in alcun luogo: "i sentieri non portano da nessuna parte, ma conducono là dove l’uomo stesso si fonda come esistenza pensante". E in questo viaggio privo di mappe e senza promesse, sta la sua potenza.
La verità analitica non si misura in “obiettivi raggiunti”, ma in verità soggettive che emergono lentamente, dolorosamente, contro la corrente del narcisismo performativo che ci intossica e inebetisce.
Il sintomo come destino
Freud lo aveva intuito con chiarezza: “tutto ciò che non sale alla coscienza ritorna sotto forma di destino” (Lettere a Wilhelm Fliess, 1895). Ciò che non conosciamo di noi stessi ci possiede. E ci comanda.
La psicoanalisi non cura in senso medico: esplora. Ti costringe a incontrare il tuo sintomo — il tuo reale, direbbe Lacan — non per eliminarlo, ma per leggerlo, abitarlo, decifrarlo. Quel sintomo che torna sempre uguale, che si ripete, che ti fa inciampare negli stessi amori tossici, nelle stesse angosce senza nome, negli stessi dubbi vecchi come il peluche con cui dormivi da bambino.
L’analisi è uno spazio dove questa coazione a ripetere può essere osservata, letta e forse interrotta.
Il desiderio come prigione
Ma l’analisi è anche — soprattutto — un confronto con il proprio desiderio. Che non è sinonimo di libertà, come ci racconta il marketing del consumo. Il desiderio, per Lacan, è strutturalmente mancante: nasce da una mancanza originaria, è sempre rivolto a qualcosa che ci sfugge, ed è articolato nel campo dell'Altro — cioè nella dimensione simbolica che struttura il nostro modo di pensare, parlare, desiderare — fatta di parole, norme, miti familiari e sociali, significati collettivi che ci precedono e ci attraversano. Proprio per questo, non ci appartiene mai del tutto, non è mai del tutto opera mia e basta. Come scrive Lacan: “Il desiderio dell’uomo è il desiderio dell’Altro” (Écrits, 1966). La psicoanalisi non ti dice “segui i tuoi sogni”, ti chiede piuttosto: “di chi è questo sogno? cosa dice di te il tuo desiderio?”
Nel setting analitico, dove nessuna narrazione sembra durare più a lungo della seduta che la contiene, sei costretto a misurarti con il vuoto che ti abita. E questo può creare disagio, molto disagio, ma è anche, forse, l'accesso più sicuro e diretto all'autenticità.
L’alienazione e la noia: il doppio volto dell’incontro con sé
Essere alienati oggi è normalità. Alienati nel lavoro, e già lo sapevamo fin dai tempi di Marx; ma alienati anche nei social, nei centri delle città tutti uguali, nei linguaggi abbreviati e prefabbricati delle chat, alienati perché distanti dal Sé. La psicoanalisi incrina questa anestesia dell'individuo distratto e lo costringe a reggere la noia del suo stesso pensiero. Lo obbliga a stare lì, senza click, senza via di fuga, su un lettino dove nessun algoritmo ti suggerirà come “sentirti meglio”. Davanti a te il vuoto della tua anima che cerca parole che finora non è mai riuscita a trovare, dietro di te l'analista: un'ombra più che un essere umano. A volte tuo padre, a volte tua madre, a volte te bambino, a volte te malato e moribondo. A volte un silenzio muto e sordo ad ogni tua richiesta di aiuto, a volte un oggetto di astio, di odio. A volte niente.
Il setting analitico è il contrario dell'intrattenimento: è un luogo in cui la verità non è data, ma può affiorare, anche solo per un attimo — e in quell’attimo, il passato e il presente si incontrano e il futuro cambia.
Il fondamento che manca
Heidegger lo aveva compreso con chiarezza: l’uomo è un essere gettato nel mondo, senza fondamento. Non c’è un’essenza da realizzare, ma una libertà vertiginosa con cui fare conti ogni giorno che Dio mette in terra. La psicoanalisi, in questo, non offre né certezze né consolazioni perché è un processo che scava, che smonta, che disillude ma proprio in questa disillusione si apre la possibilità della verità del soggetto.
Esserci quindi, non come performance, ma come presenza. Un intrattenersi presso una mancanza ontologicamente costitutiva ma che apre a un senso non preconfezionato dell'esistenza. Uno sforzo, quello dell'analisi, che pur senza meta riavvicina l'uomo al suo centro originario.
In conclusione
A che serve dunque fare psicoanalisi oggi?
Serve a rallentare in un mondo che corre verso il nulla che più nulla non si può.
Serve a ribellarsi alla tirannia della performance, del risultato da produrre, qualsiasi esso sia.
Serve a restituirci la parola, e con essa la possibilità di esistere davvero.
Serve a ricordarci che dentro di noi c’è qualcosa che resiste, che non si compra né si vende, che pulsa e che smuove il destino.
Serve, infine, a diventare un po’ più liberi e un po' meno stanchi — anche se per farlo c'è da camminare tanto.