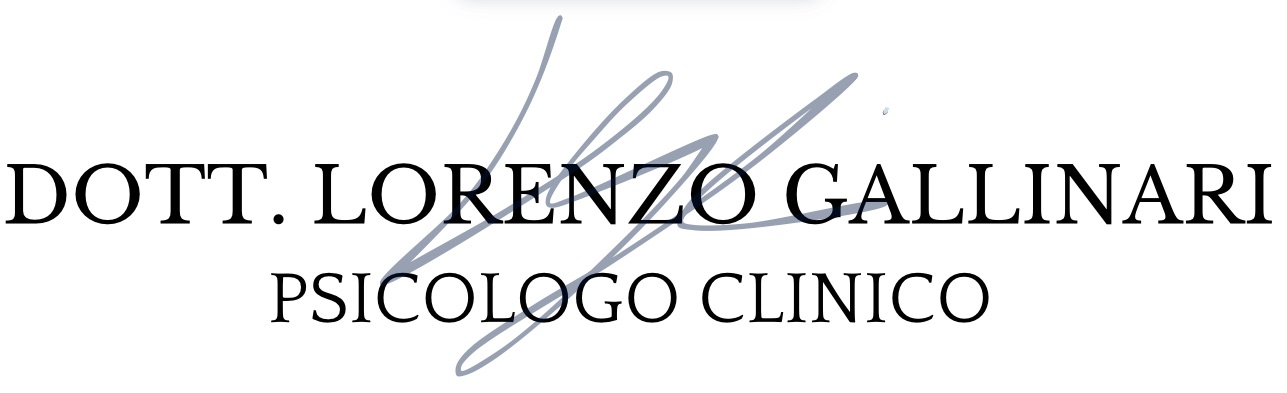Il narcisismo, oggi più che mai, appare come una delle caratteristiche dominanti della nostra epoca. Lungi dall’essere un semplice disturbo della personalità, esso sembra diventato una vera e propria condizione esistenziale, plasmata dalle dinamiche economiche, sociali e culturali del neoliberismo. Il paradigma neoliberista, con il suo incessante culto della competitività, della performatività e dell’autorealizzazione individuale, ha profondamente ridefinito il modo in cui gli individui percepiscono sé stessi e il proprio ruolo nel mondo.
Gli imprenditori di sé stessi
Il neoliberismo non è soltanto un modello economico, ma un’ideologia pervasiva che influenza ogni aspetto della vita. Esso impone una logica che trasforma ogni individuo in un imprenditore di sé stesso, costretto a investire incessantemente in ogni aspetto della propria esistenza: dalle relazioni personali alla propria immagine, dal lavoro alla gestione del tempo libero. Questo modello impone l’idea che l’individuo sia sempre responsabile del proprio successo o fallimento, senza lasciare spazio alle circostanze, alle strutture sociali o al caso.
Michel Foucault descrive questa dinamica con il concetto di "imprenditorialità del sé", secondo cui l’individuo è chiamato a concepire la propria esistenza come un’impresa in cui ogni scelta, ogni comportamento, ogni relazione deve essere ottimizzata per garantire la massima efficienza e visibilità. Questa logica porta inevitabilmente a una crisi dell’identità, in cui il sé si frammenta sotto la pressione della performance costante e della necessità di dimostrare il proprio valore in ogni ambito della vita.
I desublimati
Il neoliberismo non si limita a imporre un’ossessione per la performance, ma ridefinisce anche la sfera del desiderio. Herbert Marcuse ha parlato di "desublimazione repressiva", un processo attraverso il quale le pulsioni vengono incanalate in forme di consumo immediato, impedendo una loro elaborazione simbolica più profonda. L’individuo neoliberista, spinto dalla logica del godimento senza limiti, si ritrova costantemente alla ricerca di gratificazioni effimere che, paradossalmente, non fanno altro che amplificare il senso di vuoto.
Slavoj Žižek ha approfondito questo tema attraverso la lente della psicoanalisi lacaniana, sottolineando come il desiderio, nel contesto neoliberista, sia costantemente manipolato e deformato dalla logica del mercato. La promessa di una soddisfazione continua si traduce in una perenne insoddisfazione: l’individuo non raggiunge mai un punto di appagamento, ma è spinto a rincorrere nuovi oggetti del desiderio che si rivelano sistematicamente insoddisfacenti.
Ma quanto mi ami?
In questo scenario, il narcisismo assume una nuova configurazione. Se tradizionalmente il narcisismo era inteso come una fissazione su di sé, oggi esso appare come una forma di adattamento alle richieste della società neoliberista. L’individuo costruisce un’immagine performativa di sé, calibrata in base alla ricezione esterna, costantemente esposta al giudizio altrui attraverso i social media e altre forme di visibilità pubblica.
Tuttavia, dietro questa facciata di autosufficienza si cela una fragilità profonda. L’individuo narcisista neoliberista è perennemente insicuro, dipendente dalla validazione esterna e incapace di tollerare il fallimento. L’assenza di uno spazio per la vulnerabilità e l’errore genera un’ansia costante, che si manifesta in disturbi dell’umore, sindromi da burnout e una diffusa sensazione di alienazione.
Press Pause
Se il narcisismo neoliberista è il prodotto di un sistema che impone la performance costante e il godimento immediato, la resistenza non può che passare attraverso una riscoperta della dimensione dell’incompiutezza e della vulnerabilità. Come suggerisce Thomas Fuchs, è necessario recuperare un senso di coesione esistenziale che vada oltre la frammentazione imposta dalla logica di mercato.
L’autenticità non può essere ridotta a un prodotto da esibire, né il valore personale può essere misurato esclusivamente in base alla performance. Occorre riscoprire spazi di relazione non performativi, momenti di pausa e riflessione che permettano all’individuo di sottrarsi alla logica dell’efficienza e di riconnettersi con il proprio sé autentico.
In un mondo che spinge incessantemente verso la competizione e l’auto-ottimizzazione, la vera sfida è forse quella di imparare nuovamente a esistere senza dover sempre dimostrare qualcosa. Solo così sarà possibile immaginare una società in cui l’identità non sia più una costruzione precaria da vendere al miglior offerente, ma un processo fluido e autentico di esplorazione e scoperta.