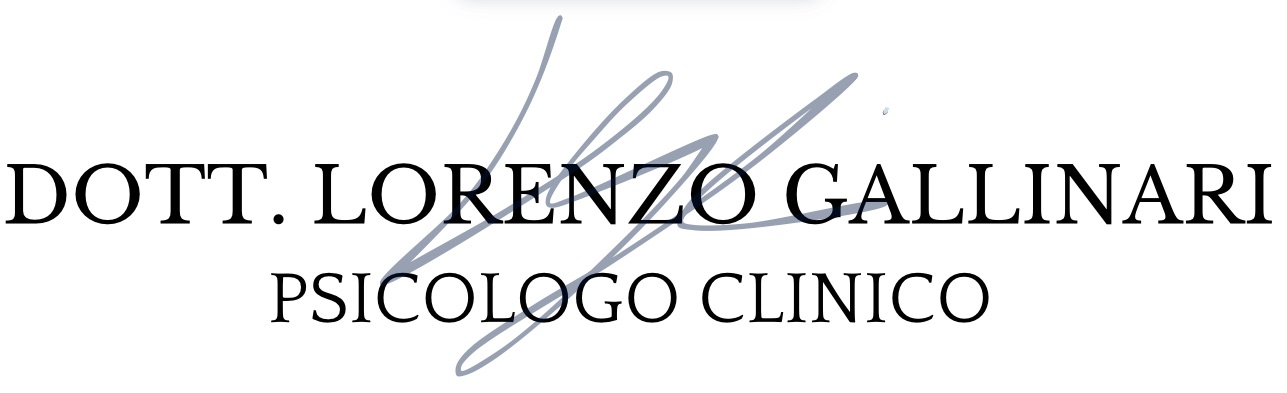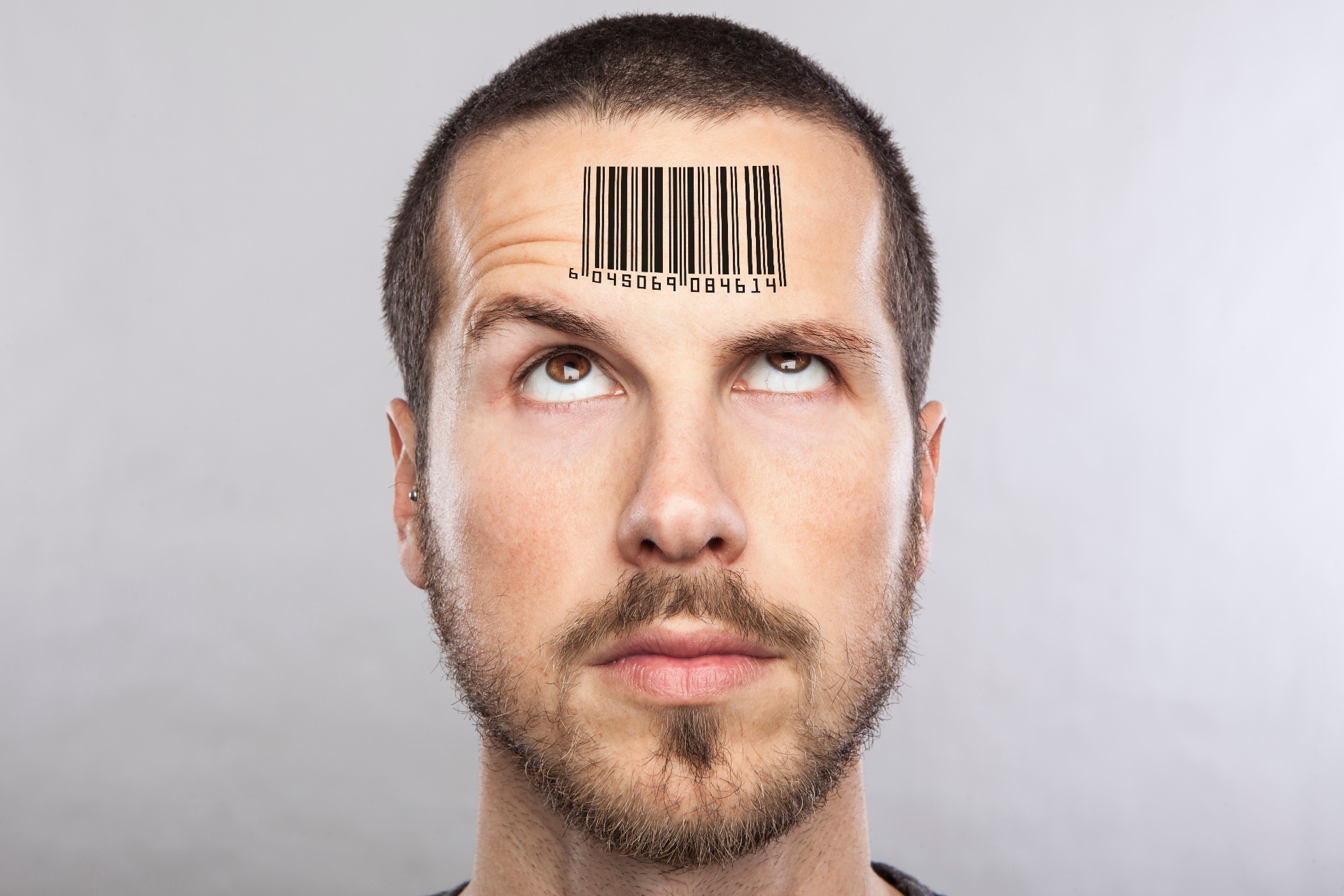La propensione al consumo oggi non è solo un'attività economica, ma un elemento che struttura il modo in cui percepiamo noi stessi e il mondo che ci circonda. Gli oggetti non sono più solo strumenti di utilità, ma elementi attraverso cui costruiamo identità, status e significato. Ciò che possediamo può arrivare a influenzare profondamente il modo in cui ci definiamo e interagiamo con gli altri. In che misura questa dinamica modifica il nostro senso del valore e il modo in cui costruiamo le relazioni??
Il Grande Altro - Market Place
Nella contemporaneità, il mercato non è più solo un meccanismo economico, ma una struttura simbolica che determina i desideri e le aspirazioni individuali. Secondo la lettura di Lacan e Žižek, il mercato opera come un "Grande Altro" che non impone regole in modo diretto, ma modella i comportamenti attraverso la promessa di realizzazione personale mediata dagli oggetti di consumo. Ogni prodotto si presenta come il possibile riempimento di una mancanza, come una risposta definitiva a un bisogno, eppure questo bisogno non si esaurisce mai, generando un ciclo infinito di desiderio e frustrazione.
Se ci fermiamo a riflettere, quante volte abbiamo acquistato un oggetto convinti che ci avrebbe reso più felici, per poi renderci conto, poco dopo, che il desiderio si era spostato su qualcos'altro? L’insoddisfazione, anziché essere un errore del sistema, è la sua condizione di funzionamento.
Acquista con un click
La società neoliberista ha perfezionato un meccanismo per cui il desiderio non si orienta più verso esperienze autentiche o relazioni significative, ma verso prodotti sempre nuovi. Questa dinamica trasforma il soggetto in un consumatore perpetuo, intrappolato nella ricerca di un godimento illusorio. Il mercato crea oggetti piccoli "a" - per usare il linguaggio lacaniano, il simbolo dell'oggetto del desiderio irraggiungibile - che si presentano come risolutivi ma che, in realtà, alimentano la mancanza piuttosto che colmarla.
Non si tratta solo di un fenomeno limitato ai beni materiali: esperienze, relazioni, persino la nostra immagine corporea diventano oggetti di consumo. Si può quindi parlare di una mercificazione dell'essere? Quanto siamo ancora in grado di stabilire rapporti autentici con gli altri, al di là della logica del possesso e della prestazione?
Fino a quando mi servi
La logica del consumo non modella solo il desiderio, ma trasforma anche il modo in cui ci relazioniamo agli altri. Come osserva Bauman, le relazioni affettive stesse sono diventate "liquide", sottoposte alle stesse dinamiche di efficienza e sostituibilità che caratterizzano il mercato. Un partner, un amico, un conoscente vengono valutati sulla base di quanto strumentali sono alla realizzazione di un progetto di vita, piuttosto che per il valore intrinseco dello stare insieme. Questo produce una società in cui la solitudine e l’alienazione sono esperienze sempre più diffuse.
Possiamo ancora dire di essere liberi di scegliere le nostre relazioni, o queste sono sempre più condizionate dalla logica della convenienza e del consumo? Quando una relazione non soddisfa più le aspettative, il paradigma della sostituzione diventa quasi automatico, proprio come accade con gli oggetti di consumo.
Sempre al Top
Nel sistema attuale, la stessa identità personale viene mercificata. I social media, in particolare, hanno reso la presentazione di sé un’attività performativa, in cui si cerca di massimizzare il valore percepito attraverso immagini, esperienze e narrazioni ottimizzate. Il rischio di questa spettacolarizzazione del sé è la perdita di autenticà: quanto di ciò che mostriamo corrisponde davvero a chi siamo?
La pressione a conformarsi a modelli di successo e attrattività contribuisce a un senso di inadeguatezza diffuso. Se l'identità è ridotta a un modello da vetrina, il senso di integrità e coerenza che ho con la mia interiorità viene rimpiazzato dall’approvazione dello spettatore: la mia identità diventa soggetta alle stesse logiche che governano i prodotti sul mercato.
L’alienazione prodotta dalla società del consumo si manifesta non solo in una disconnessione dagli altri, ma anche in una frattura interna all’individuo. L'essere umano, intrappolato in un ciclo di desiderio e insoddisfazione, fatica a entrare in contatto con i propri bisogni autentici. Il consumo compulsivo e la ricerca ossessiva di nuove esperienze diventano strategie di fuga da un senso di vuoto interiore che non trova altro modo di essere colmato.
La domanda che sorge spontanea è: siamo ancora in grado di desiderare al di fuori delle logiche imposte dal mercato? O il nostro desiderio è ormai interamente catturato da una struttura che lo governa e lo orienta secondo finalità economiche?
Selfie-free Zone
Per sottrarsi alla logica della mercificazione del proprio desiderio, diventa essenziale riappropriarsi della capacità di riconoscerlo e differenziarlo dai dettami del mercato. Questo significa spostare l’attenzione dal possesso alla relazione, dall'accumulazione all'esperienza, dall’efficienza alla gratuità, riscoprendo il valore di una vita che non risponde esclusivamente alle logiche della performance.
Riscoprire la profondità dei legami, il valore del tempo improduttivo, il piacere di un’esperienza vissuta senza un selfie che la catturi: sono questi gli strumenti per riconnettersi a un’esistenza meno alienata. Non si tratta di demonizzare il consumo in sé, ma di rimetterlo in una prospettiva in cui non sia più l’unico strumento attraverso cui attribuiamo valore alle cose e alle persone.
Forse il vero atto di resistenza oggi è il rallentare, concedersi il lusso di un desiderio che non sia né utile né proficuo. Possiamo ancora immaginare una società in cui il valore del tempo percepito sia superiore a quello degli oggetti comprati??