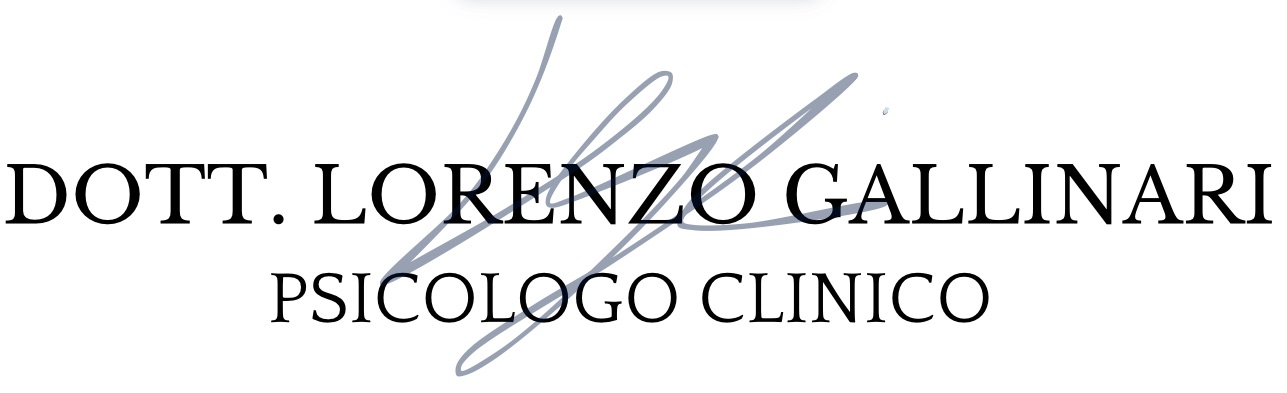La società post-industriale del XX e XXI secolo si è sviluppata in un contesto dominato dalla logica neoliberista, che non si limita alla sfera economica, ma penetra nel tessuto sociale e psicologico degli individui. Questo paradigma ha trasformato radicalmente il modo in cui concepiamo il successo, la responsabilità e la realizzazione personale. Uno dei suoi pilastri fondamentali è l’idea che l’essere umano sia un imprenditore di sé stesso, chiamato a gestire ogni aspetto della propria esistenza secondo principi di efficienza e competitività. L’autosufficienza viene esaltata come valore assoluto, diventando condizione sine qua non di ogni forma di esistenza produttiva.
Se da un lato questo modello promette libertà e autorealizzazione, dall’altro impone un costante stato di inadeguatezza, in cui il valore individuale è misurato sulla base della performance e della capacità di prevalere sull'altro secondo la logica della competitività. In questo scenario, il fallimento non è mai concepito come una possibilità di rimessa in questione sana o di un' eventuale analisi del contesto sociale più ampio, ma viene interiorizzato come una colpa personale, alimentando ansia, insicurezza e un senso di alienazione che pervade ogni aspetto dell’esistenza.
Homo Oeconomicus
Michel Foucault, nella sua analisi del neoliberismo in Nascita della biopolitica, introduce il concetto di homo oeconomicus come una figura centrale della razionalità iper-efficiente della nostra contemporaneità. L’individuo non è più concepito come parte di un tessuto sociale solidale, ma come un'entità isolata, chiamata a massimizzare la propria produttività e a gestire ogni aspetto della propria vita come fosse un’impresa economica. L’autosufficienza diventa l’ideale supremo, mentre la dipendenza dagli altri viene stigmatizzata come una sorta di difetto da cui proteggersi.
In questa prospettiva, ogni ambito dell’esistenza viene valutato secondo logiche di efficienza e rendimento: il tempo libero è trasformato in un’occasione per migliorare il proprio capitale umano, i rapporti interpersonali assumono una funzione strumentale e persino il corpo diventa un oggetto da ottimizzare. Ma quali sono le conseguenze psicologiche di questa incessante performatività?
Narciso è un perdente
Se il successo è presentato come il risultato esclusivo del merito individuale, il fallimento diventa una colpa personale. La narrativa neoliberista non lascia spazio all'importanza dei rapporti umani e della reciprocità: ogni insuccesso è visto come un deficit di impegno, di talento o di capacità. Questo meccanismo genera un senso di mancanza pervasivo, una paura costante di non essere abbastanza competitivi o aggiornati, che può tradursi in ansia, depressione e disturbi legati alla percezione del sé.
Jonathan Shedler e Nancy McWilliams hanno evidenziato come il senso di inadeguatezza tipico delle società ipercompetitive possa portare a forme di narcisismo patologico o a stati di depressione profonda. L’identità dell’individuo viene costantemente misurata sulla base di risultati esterni, creando un circolo vizioso in cui l’autostima diventa dipendente dall’approvazione altrui e dai successi ottenuti. Questo fenomeno è esacerbato dai social media, che impongono un modello di visibilità e validazione continua, rafforzando l’idea che il valore personale sia direttamente proporzionale alla propria capacità di apparire vincente.
Chi fa da sé...
La retorica dell’individuo autosufficiente ha anche un effetto diretto sulla qualità delle relazioni interpersonali. L’idea di doversi sempre dimostrare indipendenti riduce la capacità di sviluppare legami autentici e profondi. L’empatia e la solidarietà vengono sostituite dalla competizione, mentre la vulnerabilità è vissuta come un difetto da nascondere.
Heidegger, con il concetto di Mitsein (essere-con), sottolinea l’essere-con-gli-altri come elemento costitutivo dell’esistenza umana: l'uomo non è mai se non con qualcuno o per qualcuno. Tuttavia, nella società neoliberista e post-industriale, questa dimensione viene progressivamente erosa. Ogni relazione tende a essere strumentalizzata, valutata in termini di utilità e di vantaggi concreti, piuttosto che come spazio di autenticità e condivisione. L’individuo, costantemente impegnato a dimostrare il proprio valore, fatica a riconoscere i propri bisogni emotivi e a chiedere aiuto, incrementando il rischio di isolamento e disagio psicologico. La pressione a essere autosufficienti trasforma la vulnerabilità in paura, rendendo sempre più difficile accettare la propria condizione di dipendenza dagli altri come parte integrante dell’esistenza.
Di fronte a questa deriva individualistica, diventa fondamentale ripensare i modelli di realizzazione personale e collettiva. Il recupero di una dimensione relazionale autentica, basata sulla reciprocità e non sulla mera utilità, può rappresentare un antidoto al senso di alienazione prodotto dalla logica neoliberista.
Forse essere originali oggi non implica trovare l’ennesima strategia per aumentare la produttività, ma riscoprire la fragilità come elemento fondamentale dell’esperienza umana. Riuscire a sottrarsi alla pressione costante della performance significa recuperare la possibilità di esistere al di fuori dei parametri imposti dal mercato, riscoprendo il valore della lentezza, della condivisione e della gratuità nei rapporti umani.
Possiamo ancora immaginare un mondo in cui il valore di una persona non sia definito dalla sua capacità di essere performante e autosufficiente? O siamo ormai completamente assorbiti dalla logica dell’homo oeconomicus?